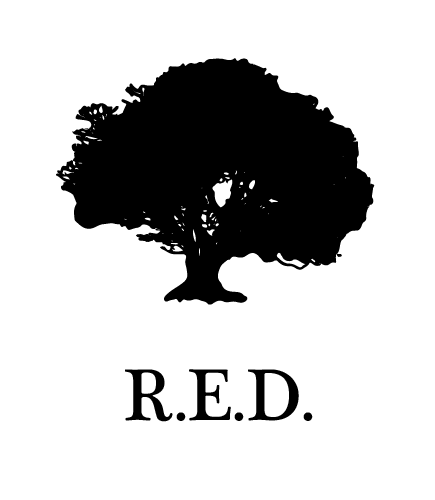Ciospa, cozza, scorfana, racchia, mostro, strega… la donna brutta ha più nomi di Dio, scrive Giulia Blasi nel suo libro “Brutta. Storia di un corpo come tanti” (Rizzoli, 2021) dove si parla solo del corpo più politico e militarizzato in quasi tutte le culture e religioni: il corpo femminile. Luogo su cui leggi, divieti, desideri, violenze e controlli, standard e pregiudizi, canoni e modelli, idealizzazioni e paure si sono succeduti ed alternati, a volte intrecciandosi, e rendendo l’ideale della bellezza femminile quanto di più incoerente e mutevole si possa immaginare. Un ideale che ha sempre avuto asticelle esasperate e irraggiungibili: troppo grassa, troppo magra, troppo piccola, troppo alta, fianchi troppo larghi o troppo stretti, seni inesistenti o floridissimi, volumi o corpi sottili quasi elfici…
Non sempre sono state le donne a disegnare lo skyline della perfezione ma, spesso, troppo spesso, sono state complici di questo processo faticosissimo di adeguamento al modello stereotipato più adeguato e riconoscibile.
E, se la bandiera del body positivity è poco convincente, dall’altra parte l’accusa di cadere nell’ipocrisia è altrettanto facile.
Forse è utile fare lo sforzo di uscire dalla dicotomia, abbandonando parole come accettazione o diversità per guardarne un’altra: varietà. Se il femminismo ha sputato su Hegel, non possiamo noi oggi sputare sui canoni estetici?
Una parte di noi vorrà sempre essere vista, apprezzata, amata e desiderata da tutti perché ci specchiamo tutte (tutti) nello sguardo dell’altro. Aggrappandoci al positivity della nostra specialità, accarezzando con ironia le nostre imperfette sfumature e investendo, speranzose… sulla genetica.